L'italiano in cucina: parole e fornelli
- 25 giugno 2014
Dalla pizza agli anolini, dal cocomero al kebab la lingua della cucina è uno specchio dell'identità italiana: l'Accademico Ugo Vignuzzi propone ai lettori una riflessione sull'importanza storica, la varietà e la plasticità dell'italiano della gastronomia.
Luglio 2014
Ugo Vignuzzi (Università "La Sapienza", Roma)
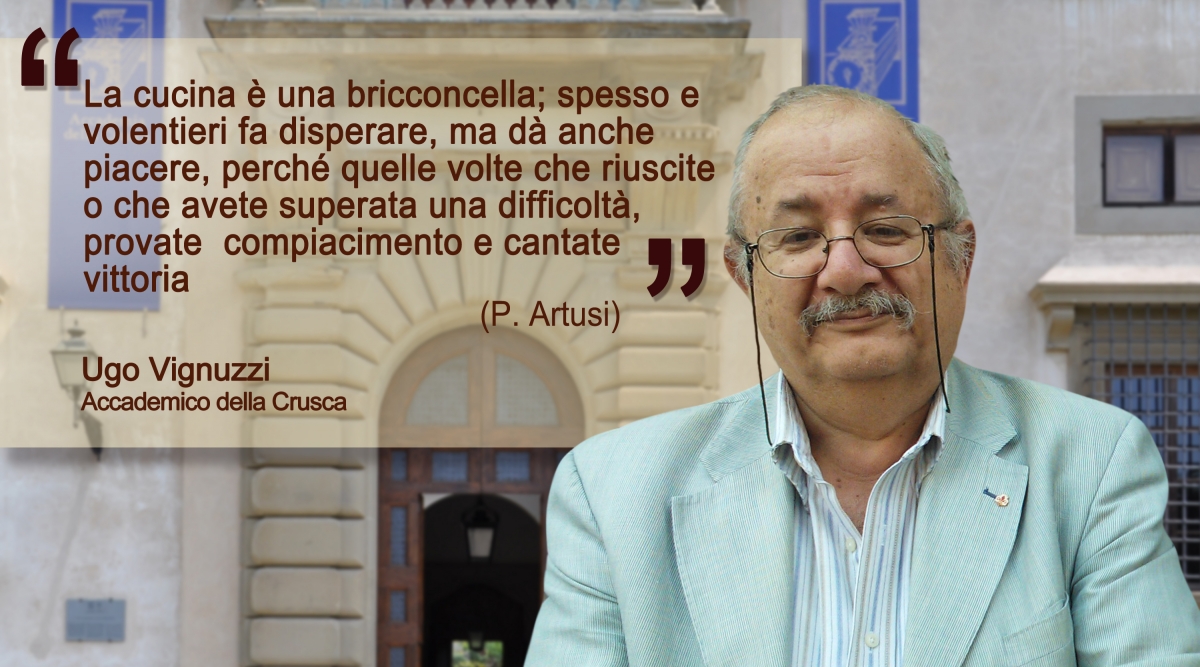
"La cucina è una bricconcella; spesso e volentieri fa disperare, ma dà anche piacere, perché quelle volte che riuscite o che avete superata una difficoltà, provate compiacimento e cantate vittoria" (P. Artusi, Prefazio alla Scienza in cucina).
Oggi, nel mondo, la parola italiana più diffusa è pizza, ma se torniamo indietro, anche solo agli anni Quaranta del Novecento, il termine (e il succulento cibo cui si riferisce) era praticamente sconosciuto fuori dell'Italia meridionale («la pizza, tolta dal suo ambiente napoletano, pareva una stonatura e rappresentava una indigestione» M. Serao 1884). Del resto, se ci basiamo sulla tradizione più diffusa, è nel giugno 1889 che il cuoco Raffaele Esposito avrebbe creato la pizza Margherita, con pomodoro (rosso), mozzarella (bianca) e basilico (verde) a riprodurre il Tricolore, dedicandola a Margherita di Savoia, regina d'Italia. E anche nella Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene di Pellegrino Artusi (I ed. 1891; XIV ed. 1910), quel Manuale pratico per le famiglie che tra fine Ottocento e primo Novecento si poté affermare come una sorta di Bibbia della cucina borghese italiana, la Pizza alla napoletana (ricetta n. 609) è un dolce a base di pastafrolla, ricotta e mandorle.
Ma l’importanza del volume artusiano va ben oltre il piano gastronomico: come è stato autorevolmente affermato, la Scienza in cucina ha svolto nell'unificazione linguistica italiana sul modello toscofiorentino un ruolo paragonabile a quello dei Promessi sposi. Proprio nella Scienza in cucina per altro si dà conto e spazio alla componente localistica, a quella che potremmo chiamare l'Italia delle Italie della gastronomia, proponendo ricette di varia origine, talora suggerite dagli stessi lettori, spesso donne di casa, massaie. Ecco allora il celeberrimo esempio della ricetta degli Anolini alla parmigiana, inviata da una signora di Parma ad Artusi, che si dichiara «obbligato alla prefata signora perché avendo messo in prova la detta minestra è riuscita di tale mia soddisfazione da poter rendermi grato al pubblico e all’inclita guarnigione»: del resto, potremmo guardare al manuale dell'Artusi come a una sorta di blog gastronomico realizzato con gli strumenti dell'epoca. Non è un caso che i primi repertori complessivi delle cucine regionali appaiano dopo Artusi (La nuova cucina delle specialità regionali di V. Agnetti, Milano 1909; Guida gastronomica d'Italia, nelle Guide del Tourig Club Italiano, 1931).
Insomma, la cucina italiana, apprezzatissima ambasciatrice nel mondo dell'Italian style of life, è uno specchio perfetto della nostra complessa e composita identità, unitaria, sulla base di una tradizione culturale plurimillenaria e di livello altissimo, e insieme fortemente legata al territorio, cioè "localistica, municipale": sub specie linguistica ecco allora i moltissimi regionalismi soprattutto novecenteschi (e pizza non ne è che l'esempio più importante, anche per il collegamento con la nostra emigrazione transoceanica), gli altrettanto numerosi dialettalismi sempre più ampiamente diffusi anche in località lontane da quelle d’origine, ma pure i non pochi geosinonimi (i termini che indicano, con denominazioni diverse a seconda delle diverse aree linguistiche, referenti identici) come a es. le famose coppie branzino / spigola o anguria / cocomero (e persino geoomonimi, per cui la stessa parola rinvia a realtà alimentari talora diversissime in aree geografiche differenti, si pensi a gnocco o salame). E non meno importanti quelle parole "nazionali" del tipo di pasta o cappuccino che non solo fanno il giro del mondo ma diventano perfino produttive in altre lingue.
Una cucina e una lingua, quelle italiane, che non hanno paura d'aprirsi al nuovo, anche se forestiero - come a suo tempo hanno saputo fare i fantasiosi cuochi/linguisti che nella prima metà dell'Ottocento dal francese surprise hanno tratto il nome (e chissà se non anche l'ispirazione) per i prelibati supplì -; una cucina e una lingua che sanno integrare sapientemente le novità su una base fortemente radicata nella tradizione e nel territorio; e il discorso sulle provenienze e contaminazioni "altre" delle nostre cucine regionali (e di quella nazionale) ci porterebbe assai lontano...
Di fatti nel mondo l'italiano è sempre più fortemente percepito come la lingua del buono nel senso del buon cibo e del mangiar bene: ristoranti, libri e riviste, trasmissioni e ora anche il mondo digitale (i social media del Web 2.0.) propongono e ripropongono immagini e ricette della nostra cucina, diffondendo insieme alla cultura gastronomica italiana, un modello linguistico sostanzialmente unitario, di tono medio ma aperto al "parlato" e non ostile programmaticamente all'apporto straniero (dal kebab al sushi, dal wok al, o alla, tajin).
1 COMMENTI
Il tema corrente
Lorenzo Tomasin
Il nome (improprio) della cosa: quella artificiale non è intelligenza
"Se abbiamo stabilito che quella che chiamiamo intelligenza artificiale di fatto non è una forma d’intelligenza, perché di essa le mancano alcune caratteristiche fondamentali, è chiaro che l’artificiosità che ne caratterizza le tecniche non si applica a nulla di intelligente, né potenzia o migliora alcuna prestazione intellettiva. Perché, semplicemente, non sono intelligenza": l'Accademico Lorenzo Tomasin invita a confrontarsi sull'uso dell'espressione intelligenza artificiale.
Archivio Temi
Maria Teresa Zanola
L’italiano, una lingua internazionale (contro l’Italian sounding)
"La dimensione internazionale dell’italiano porta l’attenzione alla cultura italiana - dall’arte alla musica, dalla scienza alla gastronomia -, superando la diffusione del “falso” italiano": l'Accademica Maria Teresa Zanola invita a riflettere sulla questione del rilancio commerciale dell'italianità e di come questo abbia impatto sulla lingua.
Claudio Marazzini
Il rapporto PIAAC-OCSE 2024
Il presidente onorario Claudio Marazzini commenta i dati sull'alfabetizzazione e sulle competenze linguistiche e letterarie degli italiani fornite dal rapporto PIAAC-OCSE 2024.
In Toscana c’è il dialetto?
I dialetti sono stati più volte oggetto del Tema. In questa occasione Annalisa Nesi, accademica segretaria, invita a discutere sul dialetto in Toscana.
Agenda eventi
Evento di Crusca
Collaborazione di Crusca
Evento esterno
Avvisi
Non ci sono avvisi da mostrare.



Rispondi