La “Grande Guerra” e gli italiani nella trincea della lingua
- 06 marzo 2014
Francesco Sabatini propone ai nostri lettori una riflessione sull'impatto che la Prima Guerra Mondiale ha avuto sulla lingua degli italiani.
Marzo 2014
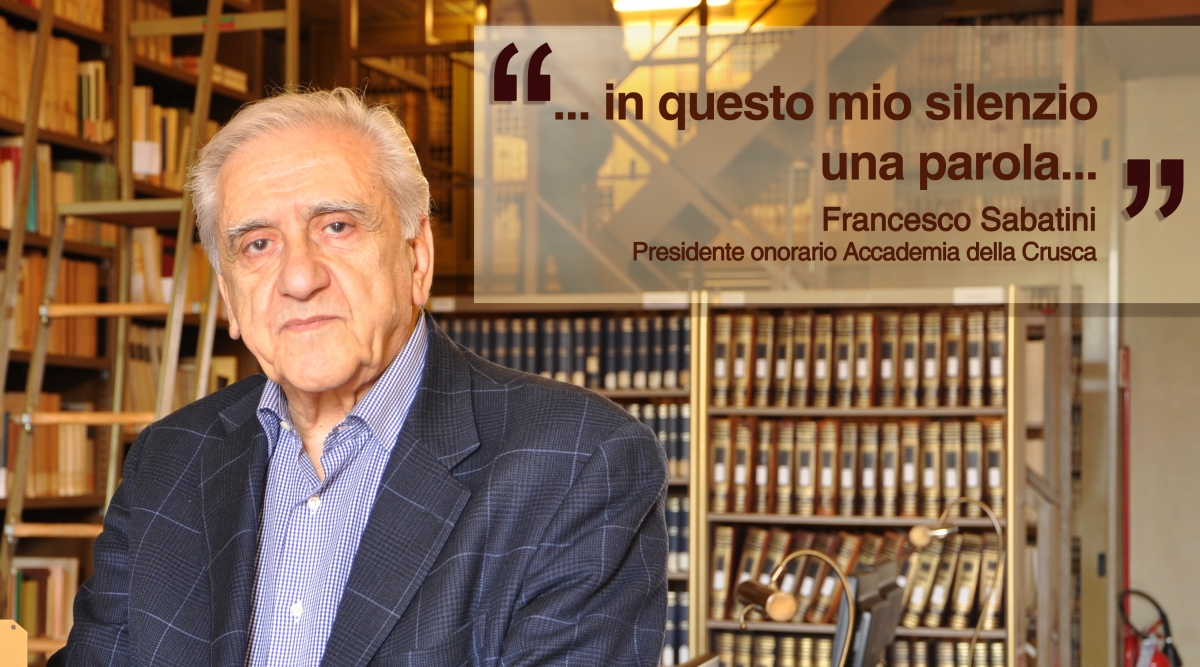
"... in questo mio silenzio
una parola..."
G. Ungaretti, Commiato
La “Grande Guerra” fu l’evento che, insieme con le bibliche migrazioni dei decenni precedenti, movimentò nel profondo, come mai era accaduto da oltre un millennio, l’intera popolazione della Nazione italiana. Quell’evento portò alla luce anche le fortissime diseguaglianze economiche e culturali esistenti tra i diversi strati sociali e tra le diverse aree del Paese e, in particolare, rivelò quanto fosse ancora priva di capacità linguistiche adatte alla comunicazione efficace, interclasse e interregionale, una buona metà della popolazione. Nel decennio 1911-1921 l’analfabetismo in Italia era intorno al 40%, quando in Germania, Austria e Paesi europei del Nord era all’1%.
La lontananza dalle proprie famiglie e dal proprio luogo di vita, i patimenti della trincea o della prigionia, il costante pensiero rivolto alla morte fecero sentire alla massa dei soldati il dramma della solitudine linguistica. Si avvertì allora acutamente da parte loro, com’era stato per le schiere di emigrati, il bisogno di conquistare, insieme con l’italiano, l’uso della scrittura: le tante dichiarazioni pervenuteci di questi fatti e la testimonianza diretta delle lettere, dai combattenti ai familiari e viceversa, scritte o fatte scrivere con le minime capacità disponibili sono tra i documenti più veritieri delle condizioni di vita ereditate dal passato e del cammino assai lungo che milioni di Italiani dovevano ancora percorrere per consolidare la propria posizione di cittadini di uno Stato e abitanti nel mondo moderno.
9 COMMENTI
Il tema corrente
Lorenzo Tomasin
Il nome (improprio) della cosa: quella artificiale non è intelligenza
"Se abbiamo stabilito che quella che chiamiamo intelligenza artificiale di fatto non è una forma d’intelligenza, perché di essa le mancano alcune caratteristiche fondamentali, è chiaro che l’artificiosità che ne caratterizza le tecniche non si applica a nulla di intelligente, né potenzia o migliora alcuna prestazione intellettiva. Perché, semplicemente, non sono intelligenza": l'Accademico Lorenzo Tomasin invita a confrontarsi sull'uso dell'espressione intelligenza artificiale.
Archivio Temi
Maria Teresa Zanola
L’italiano, una lingua internazionale (contro l’Italian sounding)
"La dimensione internazionale dell’italiano porta l’attenzione alla cultura italiana - dall’arte alla musica, dalla scienza alla gastronomia -, superando la diffusione del “falso” italiano": l'Accademica Maria Teresa Zanola invita a riflettere sulla questione del rilancio commerciale dell'italianità e di come questo abbia impatto sulla lingua.
Claudio Marazzini
Il rapporto PIAAC-OCSE 2024
Il presidente onorario Claudio Marazzini commenta i dati sull'alfabetizzazione e sulle competenze linguistiche e letterarie degli italiani fornite dal rapporto PIAAC-OCSE 2024.
In Toscana c’è il dialetto?
I dialetti sono stati più volte oggetto del Tema. In questa occasione Annalisa Nesi, accademica segretaria, invita a discutere sul dialetto in Toscana.
Agenda eventi
Evento di Crusca
Collaborazione di Crusca
Evento esterno
Avvisi
Non ci sono avvisi da mostrare.



Intervento conclusivo di Francesco Sabatini
Abbiamo aperto le riflessioni del mese ricordando che cento anni fa, sui fronti del primo conflitto mondiale, l’Italia scoprì anche l’arretratezza culturale di un’alta percentuale della sua popolazione, per circa la metà ancora analfabeta. Vogliamo ora concluderle segnalando che a cento anni di distanza da quegli eventi non dobbiamo più fare i conti con la massa degli analfabeti totali, ma con un diffuso analfabetismo “funzionale”. Una scarsa padronanza dell’italiano, appreso parzialmente negli anni di scolarizzazione e non ampliato e consolidato nell’età adulta attraverso il suo uso per le funzioni sociali e culturali, mette ugualmente una gran parte della popolazione in una condizione di debolezza e improduttività.
Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi