La norma linguistica
- 14 novembre 2014
"Un errore di ortografia non comporta un'incriminazione: però può compromettere il buon esito di una prova d'esame". L'Accademico Luca Serianni propone ai lettori una discussione sul confronto fra norma giuridica e norma linguistica.
Dicembre 2014
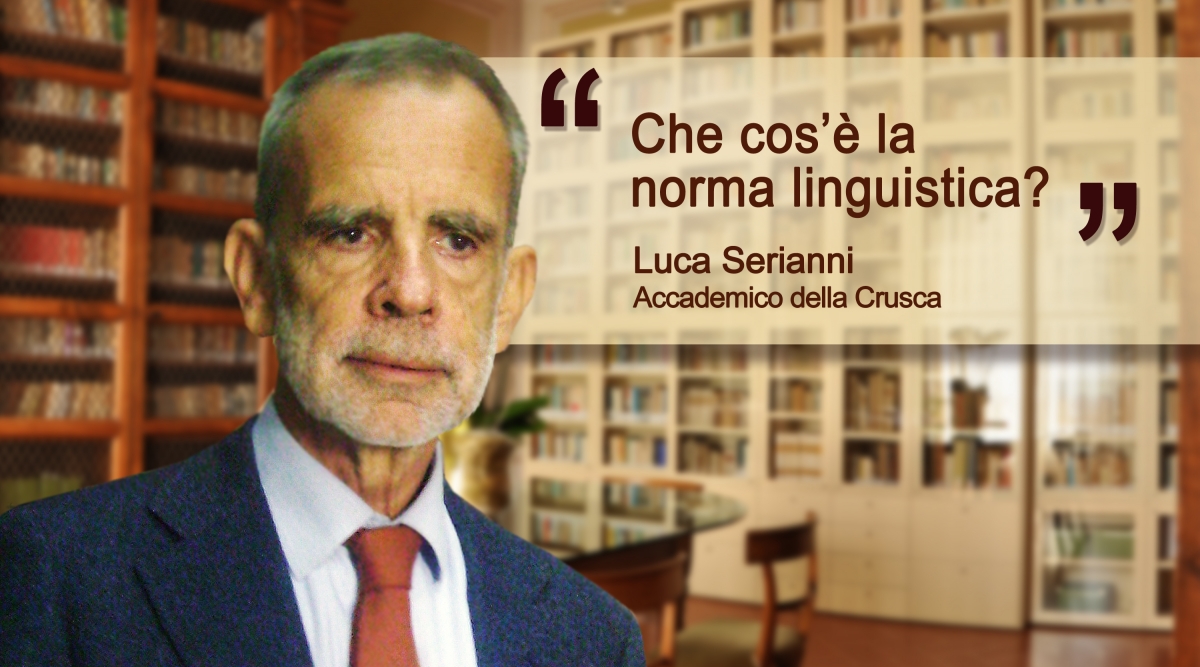
È tradizionale, anche se variamente declinato, un parallelo tra norma giuridica e norma linguistica. In entrambi i casi si ha una disposizione condivisa da una comunità, la cui violazione fa scattare una sanzione. Un errore di ortografia non comporta un'incriminazione: però può compromettere il buon esito di una prova d'esame, dalla scuola ai concorsi pubblici, e può squalificare culturalmente chi lo commette: ci fideremmo davvero di un avvocato o di un medico che scrivessero a invece di 'ha' e coleggio invece di 'collegio'? Probabilmente ci verrebbe il sospetto che siano altrettanto precarie le rispettive conoscenze in diritto processuale o in anatomia patologica.
Come sa qualsiasi matricola di Giurisprudenza, la norma giuridica riguarda l'azione esterna del soggetto, senza interferire sui suoi processi psichici che non si siano manifestati nella realtà sensibile. Anche la norma linguistica non si applica al modo in cui il linguaggio è organizzato dalla nostra mente e, in più, non riguarda quelle che possiamo considerare le condizioni primarie d'uso di una lingua. Ogni parlante madrelingua parla nelle varie situazioni quotidiane con assoluta naturalezza, come quando respira o deglutisce, senza porsi il problema del "come si dice". A nessun italofono verrebbe mai in mente di chiedersi se deve usare il pronome io, quando dice «Ricordati di me»; l'alternativa *ricordati di io non è "sbagliata": è semplicemente inesistente, è agrammaticale, come si dice in linguistica.
Ma non parliamo sempre in condizioni di spontaneità: possiamo trovarci a sostenere le nostre ragioni in un contesto formale e tendenzialmente ostile (un esame, un colloquio di lavoro, un interrogatorio di polizia). Allora diventa decisivo non solo che cosa diciamo, ma anche come: la strategia espositiva, il lessico scelto, il controllo della gittata periodale, e magari la mimica, la prossemica, l'abbigliamento. E, oltre a parlare, abbiamo molte occasioni di scrivere: in questo caso le deviazioni dalla norma sono più evidenti e stabili (anche se nell'era di Internet questo requisito ha perso rigidità).
Di qui il tradizionale peso assegnato all'ortografia che, in sé, non è certo la componente fondamentale di una lingua, visto che riguarda solo una faccia della medaglia (lo scritto, non il parlato), e per giunta quella più superficiale; ben più importanti, sul piano della competenza linguistica, sarebbero, per esempio, il dominio della gittata sintattica o la padronanza di un lessico ricco e attento alle sfumature semantiche.
Come la norma giuridica si fonda su fonti di diritto (non necessariamente codificate in un corpus di leggi: pensiamo alla common law anglosassone), così la norma linguistica si fonda su fonti, puntuali e diffuse. Tra le prime, troviamo i tradizionali strumenti sui quali si costruisce la competenza linguistica: grammatiche e dizionari; tra le seconde, l'uso dei parlanti che, qualora non susciti reazioni di rigetto nella comunità di riferimento (come gli errori ortografici che abbiamo citato in apertura), finisce con l'assumere lo statuto di norma. Oggi nessuno troverebbe più da ridire su lui soggetto o sul costrutto pollo allo spiedo che nell'Ottocento venivano considerati estranei al corretto uso linguistico: lui era riservato all'oggetto e ai casi indiretti e quel costrutto veniva bollato come francesismo. Viceversa, Leopardi poteva scrivere facci e vadi, che oggi risulterebbero errori marchiani.
Dopo tante analogie, ecco dunque una differenza fondamentale tra lingua e diritto: la maggiore volatilità delle norme linguistiche, che evolvono nell'uso reale degli utenti prima che la tradizionale codifica grammaticale ne prenda atto.
Luca Serianni/Accademia della Crusca
Allegati
IMMAGINI
Vedi
6 COMMENTI
Il tema corrente
Lorenzo Tomasin
Il nome (improprio) della cosa: quella artificiale non è intelligenza
"Se abbiamo stabilito che quella che chiamiamo intelligenza artificiale di fatto non è una forma d’intelligenza, perché di essa le mancano alcune caratteristiche fondamentali, è chiaro che l’artificiosità che ne caratterizza le tecniche non si applica a nulla di intelligente, né potenzia o migliora alcuna prestazione intellettiva. Perché, semplicemente, non sono intelligenza": l'Accademico Lorenzo Tomasin invita a confrontarsi sull'uso dell'espressione intelligenza artificiale.
Archivio Temi
Maria Teresa Zanola
L’italiano, una lingua internazionale (contro l’Italian sounding)
"La dimensione internazionale dell’italiano porta l’attenzione alla cultura italiana - dall’arte alla musica, dalla scienza alla gastronomia -, superando la diffusione del “falso” italiano": l'Accademica Maria Teresa Zanola invita a riflettere sulla questione del rilancio commerciale dell'italianità e di come questo abbia impatto sulla lingua.
Claudio Marazzini
Il rapporto PIAAC-OCSE 2024
Il presidente onorario Claudio Marazzini commenta i dati sull'alfabetizzazione e sulle competenze linguistiche e letterarie degli italiani fornite dal rapporto PIAAC-OCSE 2024.
In Toscana c’è il dialetto?
I dialetti sono stati più volte oggetto del Tema. In questa occasione Annalisa Nesi, accademica segretaria, invita a discutere sul dialetto in Toscana.
Agenda eventi
Evento di Crusca
Collaborazione di Crusca
Evento esterno
Avvisi
Non ci sono avvisi da mostrare.



Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi