Tra inglese e dialetto: una storia non solo veneta
- 05 gennaio 2017
Il presidente dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini propone una riflessione sulla valorizzazione dello studio dell'italiano all'interno di un'ottica plurilinguistica.
Gennaio 2017
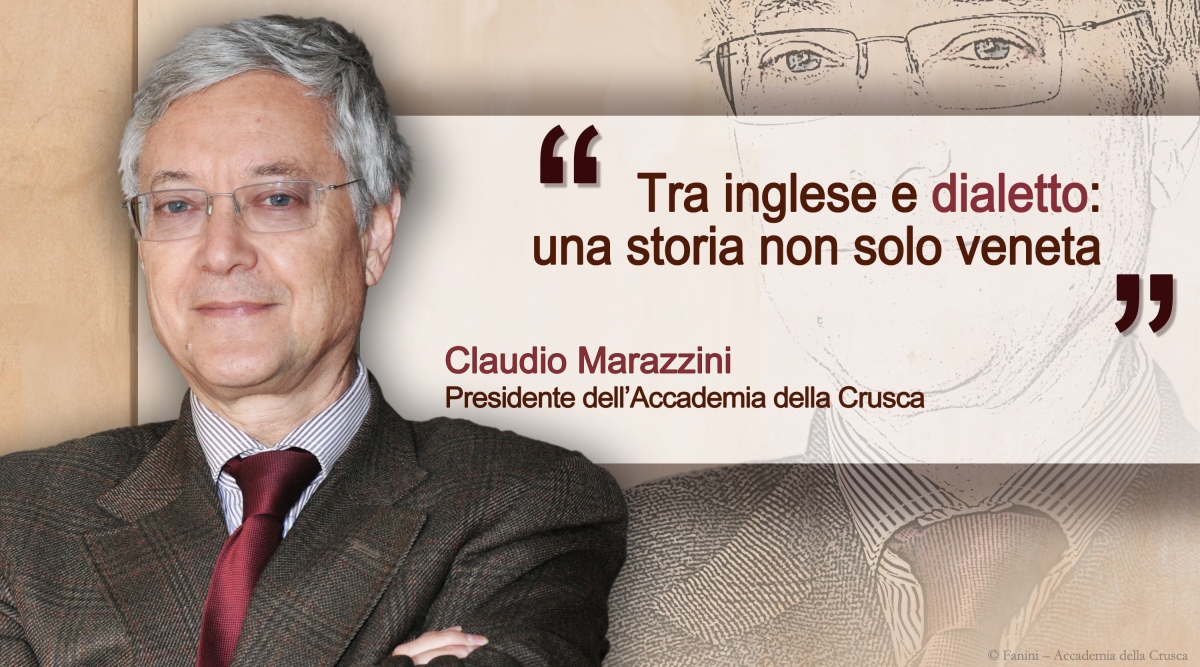
Un noto e bravo linguista veneto, Lorenzo Tomasin, che ora insegna a Losanna, ha messo on line, in Academia.edu, sito ben noto ad accademici, ricercatori e professori universitari, la fotografia di un paio di pagine del “Corriere del Veneto – Padova e Rovigo” del 9 dicembre 2016. L’editoriale del “Corriere” è firmato dallo stesso Tomasin, e condanna la confusione assai frequente tra lingua e dialetto che accompagna molte discutibili rivendicazioni linguistiche. In questo caso l’occasione per discutere sta in una legge regionale che ha dichiarato i Veneti “minoranza nazionale”. Nello stesso numero del giornale, un intervento di Luigi Migliorini prende le distanze con altrettanta forza da tale legge, invocando anche ragioni di ordine giuridico.
Va detto che leggi simili a quella del Veneto sono presenti anche altrove (ne abbiamo parlato da poco anche in questa stessa rubrica, in riferimento alla Lombardia), a tal segno che ormai, più che gridare allo scandalo, converrebbe riflettere, non tanto sulle cause di questa situazione, quanto sulle conseguenze e sulla portata reale di queste forme di protesta. Il “Corriere del veneto” è sicuramente al di sopra di ogni sospetto, perché, oltre ai due articoli già citati, sollecita il lettore anche con un terzo intervento critico, affidato a una giornalista che con scrupolo commenta la vicenda. Narra fra l’altro che Paolo Tonin, sindaco leghista di Campo San Martino, “traduce” in veneto gli atti comunali. “Per esempio, - scrive la giornalista - l’Ordine del giorno del consiglio comunale del 3 novembre scorso recita così: «Elenco degli oggetti da trattare-Lista dee robe da discutare»; «Lettura e approvazione verbali della seduta-Letura e approvasion verbai dea seduta»; «Variazione al bilancio-Variasion al biancio»; «Interpellanze-Interpeanse». Il giornale descrive anche il modo di procedere del sindaco-turcimanno: “Noi prepariamo i documenti in italiano e poi il bibliotecario li converte in veneto — spiega il sindaco —. Il via libera finale spetta a me, che intervengo per tradurre i termini più difficili. Siamo orgogliosi di tutelare le nostre radici, dopotutto la Repubblica di Venezia ha 1300 anni di storia e ha insegnato molto a quella italiana in termini di democrazia». Antiche famiglie venete, come i Bembo o i Trissino saranno liete di contemplare dall’aldilà questa evoluzione della Storia d’Italia.
Non è tuttavia di questo bilinguismo amministrativo che voglio ora parlare. Queste trovate possono far sorridere, ma non spaventano. Invece mi spaventa l’altro Veneto, quello moderno, che, sollecitato dal patriottismo del sindaco Tonin, reagisce come vedremo. Leggiamo ancora il “Corriere del Veneto”, che riporta il pensiero del presidente della “Fondazione Nord-Est”: “i veri problemi sono altri (…) Nelle aziende spesso la metà dei dipendenti, giovani e meno giovani, non parla l’inglese ed è una lacuna che va colmata in un mondo vocato all’internazionalizzazione. Ha la precedenza sul bilinguismo”. E il presidente di Confartigianato Veneto afferma: “Sono dell’idea che bisognerebbe imporre già dalla scuola materna lo studio di tre lingue straniere, altro che dialetto. Conoscere diversi idiomi abbatte le barriere ed è indispensabile per una regione in cui il 40%-50% del Pil viene fatturato nel resto del mondo. Le aziende stanno macinando utili, record di fatturati e occupazione grazie all’export, eppure la loro forza lavoro, a partire da bravissimi manager, non impara le lingue. Il dialetto lo sappiamo già, anche troppo — insiste Bonomo — i bambini, compresi i miei figli, lo apprendono all’asilo. Ma dobbiamo essere in grado di farci capire dai Paesi con i quali commerciamo, se vogliamo portare avanti un Veneto aperto al futuro”. Perché mi spaventa tutto ciò? Forse perché è male imparare le lingue straniere, magari tre o quattro la volta? Ovviamente no, se ci si riesce, e per riuscirci occorre forse un po’ meno superficialità nell’immaginare percorsi didattici. Ma il fatto è che nemmeno il sindaco Tonin, secondo me, sarebbe contro le lingue straniere, inglese e magari tedesco austro-ungarico, tutte al posto dell’italiano, con buona pace delle ceneri di Niccolò Tommaseo. Tutti costoro mostrano chiaramente quale sia la lingua che a loro non interessa: è l’italiano. Perché non si sono mai chiesti se con un buon possesso dell’italiano si imparano meglio anche le lingue straniere; e se con un miglior italiano si è cittadini un po’ migliori. Anni fa, Alfredo Stussi, che è di origine veneta, aveva ben profetizzato il rischio di uno schiacciamento dell’italiano tra esaltazioni anglofile e localismo dialettale. Riporto le parole di Stussi, così come si leggono nella rivista “Letture” del 1997, e come le ho trascritte in Da Dante alle lingue del Web (Roma, Carocci, 2013, pp. 260-61):
Mi sembra che si debba tener conto di due fatti: i dialetti resistono in maniera sorprendente; l’inglese occupa spazi sempre più vasti quale lingua di comunicazione, non solo come serbatoio lessicale. Quanto al primo fenomeno, solo venti o trent’anni fa grazie alla radio, alla televisione, alla scuola, alla burocrazia l’italiano sembrava disporre di armi tali da consentirgli una vittoria rapida e totale; invece, come è successo all’esercito russo in Afghanistan o in Cecenia, le cose sono andate diversamente, perché anche l’italiano è un gigante coi piedi d’argilla: basti pensare che la nostra scuola lascia almeno due milioni di analfabeti e che la televisione (pubblica e privata) antepone il vacuo intrattenimento alla funzione educativa di massa (mentre solo la densità della cultura produce unità e uniformità linguistica: lo aveva detto oltre centoventi anni fa il grande linguista Ascoli). Quanto all’inglese, a parte effimeri eccessi, è inutile perder tempo a discutere sull’uso di singole parole che designano prodotti culturali, industriali ecc. che così sono stati battezzati all’origine: non si vede ragione di tradurle, tanto più che spesso si tratterebbe di sostituire un monosillabo inglese con un’espressione italiana più lunga e spesso vagamente ridicola perché dotta, letteraria, artificiosa. Il punto è però, oggi, un altro: non si tratta di parole, ma globalmente della lingua inglese di cui sempre più ci serviamo e sempre più si servono soprattutto le generazioni di studiosi dai quarant’anni in giù, non per moda o esibizionismo, ma per continuare a far parte della comunità scientifica. E poiché da cinque-sei anni, grazie soprattutto alla posta elettronica, è aumentata la frequenza delle comunicazioni internazionali, sono aumentate anche le occasioni di usare quella lingua universalmente intesa. Poco tempo fa la trasmissione televisiva “Un giorno in pretura” mostrava imputati (spesso abbienti) di varie regioni, dal Veneto alla Campania, che riuscivano a esprimersi bene solo in dialetto. Mi chiedo allora se la lingua italiana non corra il rischio di tornare a essere, com’era secondo Villari prima dell’Unità, la lingua di qualche milione di arcadi, mentre i ceti produttivi useranno, a seconda del loro livello, o l’inglese o il dialetto.
Sono passati diversi anni da quando Stussi ha espresso questo triste presagio (e, si badi, per quanto ammiri Stussi, non intendo dire che io condivida proprio tutte queste sue opinioni). Quel popolo di cui qui ci parla, fragile nell’uso della lingua nazionale, anche se abbiente, esiste ancora, forse aumenta. Cerchiamo dunque di far sì che l’italiano non sia una lingua di Arcadi (questo è compito nostro, degli intellettuali che scrivono e studiano), e cerchiamo di far capire agli Arcadi del dialetto e agli Utopisti dell’inglese che una salda formazione culturale, su cui si innesta un sano plurilinguismo, comincia proprio dal possesso e dall’apprezzamento dell’italiano.
Allegati
ALLEGATIVedi
LINK
L. Tomasin, "La lingua e lo scudo dei politici (sulla legge regionale veneta relativa alla lingua)"
4 COMMENTI
Il tema corrente
Lorenzo Tomasin
Il nome (improprio) della cosa: quella artificiale non è intelligenza
"Se abbiamo stabilito che quella che chiamiamo intelligenza artificiale di fatto non è una forma d’intelligenza, perché di essa le mancano alcune caratteristiche fondamentali, è chiaro che l’artificiosità che ne caratterizza le tecniche non si applica a nulla di intelligente, né potenzia o migliora alcuna prestazione intellettiva. Perché, semplicemente, non sono intelligenza": l'Accademico Lorenzo Tomasin invita a confrontarsi sull'uso dell'espressione intelligenza artificiale.
Archivio Temi
Maria Teresa Zanola
L’italiano, una lingua internazionale (contro l’Italian sounding)
"La dimensione internazionale dell’italiano porta l’attenzione alla cultura italiana - dall’arte alla musica, dalla scienza alla gastronomia -, superando la diffusione del “falso” italiano": l'Accademica Maria Teresa Zanola invita a riflettere sulla questione del rilancio commerciale dell'italianità e di come questo abbia impatto sulla lingua.
Claudio Marazzini
Il rapporto PIAAC-OCSE 2024
Il presidente onorario Claudio Marazzini commenta i dati sull'alfabetizzazione e sulle competenze linguistiche e letterarie degli italiani fornite dal rapporto PIAAC-OCSE 2024.
In Toscana c’è il dialetto?
I dialetti sono stati più volte oggetto del Tema. In questa occasione Annalisa Nesi, accademica segretaria, invita a discutere sul dialetto in Toscana.
Agenda eventi
Evento di Crusca
Collaborazione di Crusca
Evento esterno
Avvisi
Non ci sono avvisi da mostrare.



Rispondi
Rispondi
Rispondi
Rispondi